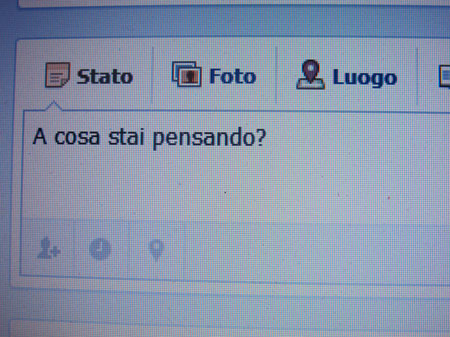di Samuel Cogliati
Facebook è diventato uno specchio abbastanza fedele di una parte della società. Statisticamente, rappresenta probabilmente ancora una minoranza, tuttavia cospicua. Agli occhi di chi frequenta questa rete sociale da qualche anno, la sua trasformazione deve sembrare evidente. Non sto parlando delle modalità di fruizione, né degli strumenti che Facebook mette a disposizione dei suoi clienti, ma dei suoi contenuti.
Da strumento usato per ritrovare amici o conoscenti perduti negli anni, Facebook è diventato un luogo di sfogo di amarezze, frustrazioni e indignazione, o di espressione dei propri entusiasmi e successi. Soprattutto, però, si è trasformato in uno spazio di esibizione personale. È curioso scoprire quante e quali persone sentano il bisogno di mostrare qualcosa di sé, di mettersi in vetrina, di fare sapere al mondo che cosa stiano facendo, mangiando, bevendo, più raramente pensando o sognando. La riservatezza sembra polverizzata, in alcuni casi assieme al senso del pudore. La vita privata diventa di pubblico dominio per molti iscritti, che si fanno prendere la mano con sorprendente facilità da quello che sembra a tutti gli effetti un gioco.
La quantità di informazioni personali – talora “sensibili”, e usate con scarsissima cognizione del rischio – messe in mostra su Facebook è impressionante. Gusti, passioni, idiosincrasie, immagini di sé, ma soprattutto gesti e azioni quotidiani inondano la piattaforma di Mark Zuckerberg. È come se sempre più persone non potessero più fare una cosa, vivere un’emozione o avere un’idea senza renderle pubbliche. Questa non è (più solo) condivisione, è ipertrofia compulsiva di sé, del proprio ego, e forse anche panico di fronte al rischio di non essere. «Posto, quindi sono. Se non posto, mi dissolvo nell’eterea, impalpabile assenza». Se le cose stessero davvero così, sarebbe molto curioso – o preoccupante – perché significherebbe una paradossale confusione dei due poli: il virtuale sarebbe presenza, la realtà assenza.
«Guardami! Se mi guardi io esisto!», sembra gridare l’assiduo frequentatore di Facebook. Stando così le cose, i post si sono moltiplicati, e i contenuti diluiti vertiginosamente. Chi posta una foto del piatto di pasta che sta mangiando, o chi scrive «e adesso una bella doccia rigenerante» si domanda chi e quanto possa interessare il suo intervento? Probabilmente no. Non è molto importante avere davvero qualcosa da dire, ma testimoniare la propria esistenza.
D’altro canto, Facebook sembra essere diventato una realtà alternativa, come se bastasse usarlo per ottenere risultati concreti (il che talvolta accade, dato che le reti sociali virtuali possono avere un deflagrante potere dissuasivo o diffamante, al punto da indurre gli interessati a prendere provvedimenti). Le persone protestano, propongono, lanciano appelli, ma non è poi dato sapere che esito o che conseguenze abbiano queste iniziative. C’è da scommettere che molte di esse restino lettera morta. Siamo al cospetto di un gigantesco paradosso. In una fase storica delle nostre vite e della nostra civiltà (occidentale e capitalistica, ma non solo) che grida vendetta, che implora partecipazione, atti concreti, impegno civico, rinnovamento sociale, intraprendenza reale, una parte della cittadinanza del mondo diserta le piazze, le botteghe, le scuole, le assemblee, per rifugiarsi sulla Rete. È un atteggiamento che stride per un verso con le stesse istanze dei grafomani di internet, e per altro verso con il disfacimento sempre più rapido della società.
In Italia, negli ultimi anni, si è sentito invocare frequentemente, anche da parte delle più prestigiose istituzioni, la “coesione sociale”. In pochi si sono però spesi a spiegare in che cosa consista. Non pare proprio che Facebook – teoricamente concepito per avvicinare le persone – stia servendo questo concetto. Non per colpa dello strumento in sé, di certo interessante, ma della scarsa padronanza e contezza che dimostrano di averne sempre più fruitori.